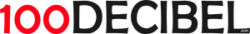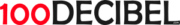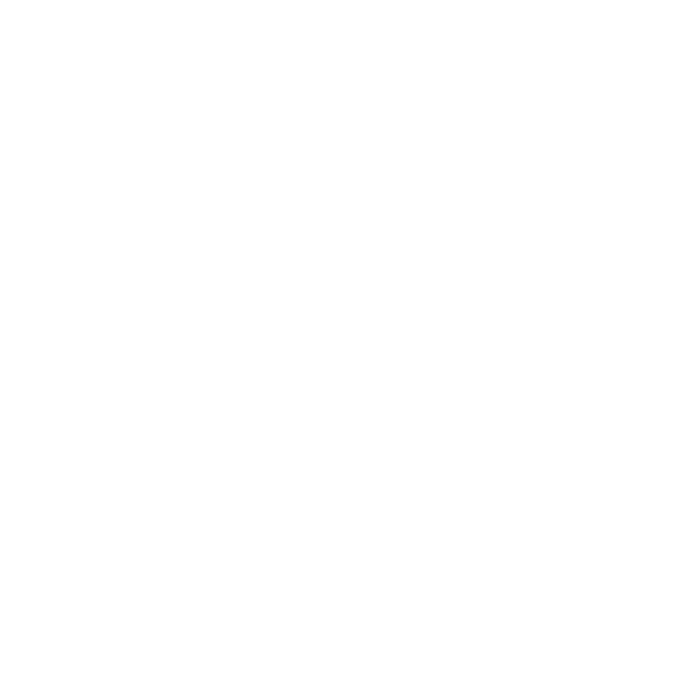Un pensiero in fuga, perso tra le chitarre soniche e circolari ma anche dolci d’indolenza elettrica, si slega dal resto e riporta indietro verso anni e voci che si perdono alla distanza, sempre più lontane e sfuggenti. Anche solo vent’anni fa sarebbe stato impensabile figurarsi un ritorno degli Slowdive, ai tempi trasfigurati nelle sembianze più folk-rock dei Mojave 3, figurarsi ipotizzare un loro concerto nella Capitale.
Un’esperienza sonora che ha saputo trascendere la realtà, portando il pubblico in una dimensione onirica e ipnotica, con qualche lieve caduta di tono da parte di una band per cui la dimensione live non è mai stata il loro reale punto di forza, ma che col tempo ha saputo lavorare al meglio sul suono che loro stessi hanno inventato, giocando di mestiere laddove qualche languore di troppo può emergere (non molti nella serata di ieri, per fortuna, giusto una ‘Crazy For You’ un po’ tirata via ed ‘Alison’ un filo troppo narcolettica).
La serata presso l’Auditorium si è aperta con un tramonto romano mozzafiato, il cielo dipinto di sfumature dorate e rosate che sembravano anticipare l’atmosfera sognante che sarebbe seguita di lì a poco. La Cavea, con la sua architettura moderna e la sua acustica perfetta, ha accolto gli spettatori (ottima affluenza ma tutt’altro che sold-out) con un abbraccio languido, creando un ambiente intimo nonostante la grandezza dell’evento.
Gli Slowdive, pionieri del dream-pop e dello shoegaze, sono saliti sul palco con una presenza calma ma magnetica. La band, composta da Neil Halstead, Rachel Goswell, Nick Chaplin, Christian Savill e Simon Scott, ha iniziato il concerto con alcuni dei brani da ‘Everything is Alive’, l’ultimo lavoro che li ha rilanciati definitivamente. Fin dalle prime note, l’audience è stata avvolta da una cascata di suoni eterei, con chitarre riverberate e voci che sembravano provenire da un’altra dimensione.
L’esecuzione è stata impeccabile, ogni nota, ogni accordo, ogni sussurro perfettamente calibrati per creare un’armonia avvolgente. Brani classici come ‘Souvlaki Space Station’ e ‘When the Sun Hits’ hanno scatenato una marea di palesi emozioni nel pubblico, molti dei quali sono stati visti chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalle melodie fluttuanti. La voce di Rachel Goswell, dolce e fragile, si è intrecciata al solito con quella di Neil Halstead, creando un contrasto affascinante che ha aggiunto profondità alle rispettive esibizioni.
Il punto culminante della serata è stato raggiunto con ‘Sugar for the Pill’, un brano che riesce a catturare l’essenza stessa della band: nostalgia euforica, languida malinconia e bellezza pura. La combinazione di synth lievi, quasi suonati in punta di dita, e chitarre scintillanti ha creato un’atmosfera quasi trascendentale, come se ogni singolo spettatore fosse trasportato in un viaggio interiore.
Ma non è stata solo la musica a incantare il pubblico. Le luci, magistralmente orchestrate, hanno giocato un ruolo cruciale nel creare l’atmosfera. Fasci di luce morbida e colori pastello hanno danzato sul palco, sincronizzati perfettamente con i ritmi e le dinamiche dei brani, trasformando ogni canzone in un quadro visivo oltre che sonoro.
Nonostante il carattere riflessivo e spesso “riservato” della loro musica, il legame tra gli Slowdive e il pubblico è stato palpabile e caloroso. Halstead e Goswell hanno interagito più volte con la platea, ringraziando i fan italiani per il loro supporto.
Con ‘Golden Hair’, la cover di Syd Barrett e presenza costante nella loro scaletta, gli Slowdive hanno lasciato il pubblico con un senso di pace e appagamento, come se avessero assistito a un rito catartico. L’encore finale è composto da tre bis ampiamente attese come la psichedelica ‘Slomo’, il gorgoglio arpeggiato di ‘Slowdive’ e il commiato consono di ’40 Days’. L’applauso finale, lungo e sentito, è stato il giusto tributo a una band che, partendo da un suono oramai ben definibile, è riuscita a fermare il ticchettio delle lancette, fuori dalle traiettorie temporali, per ascendere ad un suono dai margini universali.