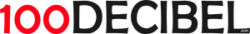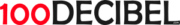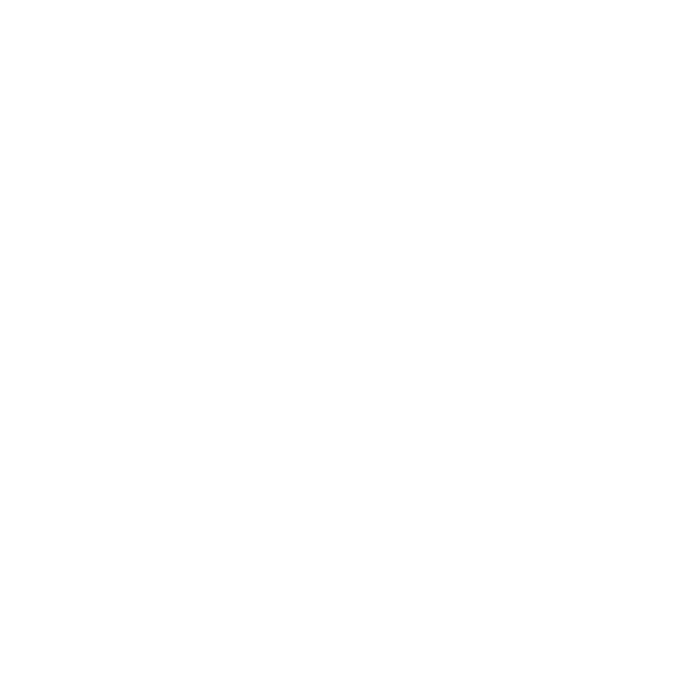Ci si potrebbe mai stancare di ascoltare i Motorpsycho, ma soprattutto di vederli dal vivo? Davvero arduo che ciò accada, e questo anche se non si è dei conclamati fan come il sottoscritto. Questo aspetto lo sottolineo proprio perchè osservo i loro concerti ed ascolto i loro dischi anche con il distacco sensoriale che potrebbe avere un neofita, qualora volesse perdersi nel loro cosmo produttivo.
La realtà è che pochi stanno dietro la band norvegese in quanto a dualismo tra longevità discografica e qualità della medesima, e questo si riflette nelle scalette dei live: date una sbirciata online alle setlist anche solo degli ultimi due mesi e non ne troverete due neanche vagamente simili.
Anche durante le due ore e mezza all’Orion (dove avevano già fatto un gran concerto nell’immediata era pre-pandemica, ovvero nel 2019) dell’altra sera ce lo hanno ricordato nuovamente, mischiando le carte in un incessante flusso di melodie sfuggenti, ampli a manetta, distorsioni lisergiche, divincolandosi al solito tra l’urgenza elettrica immediata della chitarra-Dea-del-Rock e l’etica del viaggio cosmico tra ricordi oramai lontani e immagini che si fanno impalpabili, fino ad essere inghiottite nella coltre di suoni densi e infinitamente hard-psichedelici.
In questa dicotomia trovano la propria ragion d’essere anche due cover in apparente distanza tra loro quali ‘Halleluwah‘ dei Can e addirittura un superclassico come ‘Rock Bottom’ degli UFO. Il trionfo dal vivo si rinnova nel dinamismo viscerale tra la sei corde di Hans Magnus “Snah” Ryan e del doppio manico di Bent Sæther, composto dalla sua chitarra dalle accordature cangianti e quel basso-mammooth che nessuno in epoca stoner e nemmeno in quelle successive ha mai saputo eguagliare.
E pensare che la prima parte del live è semiacustica, con alcuni brani più lievi e rilassati del loro ampio catalogo come ‘Mad Sun’ e ‘Feel‘, così come una versione quasi West Coast di ‘Sunchild‘, che dopo mezz’ora circa cede il posto alle esplosioni lisergiche di cui sopra, in un susseguirsi ed alternarsi tra brani più “giovani” (ma forse proprio quelli che più sono legati agli stilemi dei primi 70’s), ovvero provenienti dai solchi dei dischi usciti negli ultimi dieci anni, a brani che nella nostra percezione sensoriale suonano ormai come evergreen assoluti: così passano in rassegna ”On The Pillow’, ‘Pills, Powders + Passion Plays’ e la rediviva ‘Manmower‘, che scalciano più forte che in passato mostrandosi con una veste nuova pur rimanendo assolutamente riconoscibili, passando per l’umbratile ‘A Pacific Sonata‘ e una ‘Psychotzar‘ che dice tutto già dal titolo che porta in dote.
Ma inevitabilmente il fragore del pubblico è percebile fino agli anelli di Saturno quando tintinnano le prime note di un paio di brani da ‘Demon Box’, vale a dire una ‘Nothing To Say’ piuttosto rispettosa della versione originale – con quelle schitarrate grunge che li portarono per un quarto d’ora ad un pubblico più ampio del previsto – e soprattutto ‘Plan #1’, che non ascoltavo dal vivo dal loro mitico e lontanissimo concerto al Faro (centro sociale capitolino dei tempi che furono), oramai quasi trent’anni fa.
Angeli e demoni in un gioco costante, come sempre quando sul palco c’è il trio di Trondheim.
 Foto per gentile concessione di Tommaso Notarangelo
Foto per gentile concessione di Tommaso Notarangelo