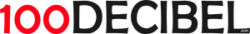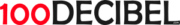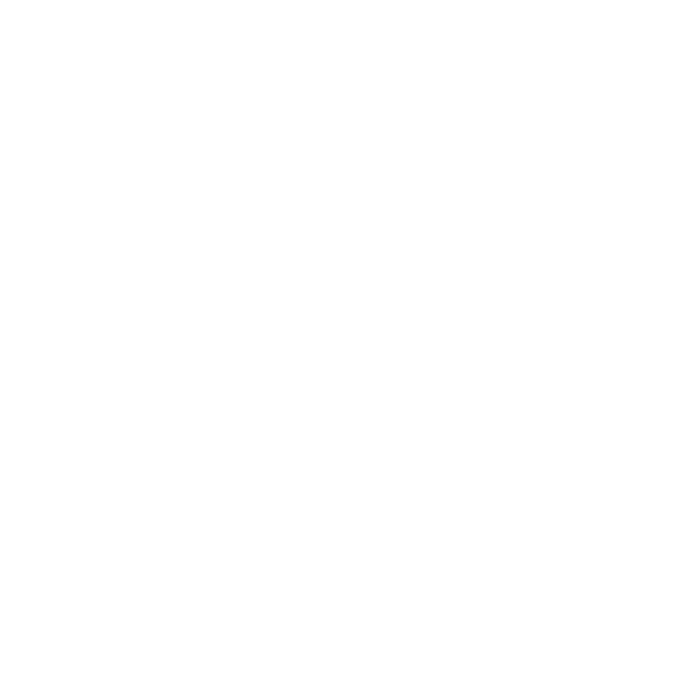Certe sere sanno di sospensione. Sabato scorso al Monk Club di Roma, ad esempio, il tempo sembrava essersi fermato, avvolto nelle trame sonore tra la voce e la chitarra di Marta Del Grandi. Una voce che non si limita a raccontare, ma trasporta, avvolge, ipnotizza. Ad accompagnarla sul palco, una formazione essenziale eppure avvolgente: un violinista, un batterista e il tecnico del suono, che oltre a tessere l’equilibrio sonoro, dava corpo al groove con il synth bass.
Il cuore della serata è stato ‘Selva’, album che conferma l’evoluzione artistica di Marta, un’opera che respira tra suggestioni cinematografiche e richiami alla natura più profonda. “Two Halves”, “Chameleon Eyes” e “Mata Hari” hanno fatto vibrare l’aria del Monk, lasciando spazio a momenti di pura contemplazione alternati a crescendo ipnotici. La batteria, liquida e pulsante, si intrecciava con il violino, mentre la sei corde ricamava un tappeto sonoro denso, capace di sostenere e amplificare ogni sfumatura vocale della cantautrice.
Ma la magia non si è fermata al nuovo album. Dall’esordio ‘Until We Fossilize’ sono riemerse canzoni come stanze dimenticate, piene di riverberi e malinconie lunari, come la splendida ‘Somebody New’, densa di scarna bellezza e languido abbandono. Marta si muove con grazia tra le armonie del suo percorso musicale, senza nostalgia, ma con la consapevolezza di chi esplora una “tradizione” tentando di tracciare un sentiero del tutto personale.
Tutt’altro che schiva, anzi, la cantautrice meneghina scherza col pubblico, con un’ironia “sospesa” autentica, e si lascia anche andare al gioco dlle cover, ovvero ospitando sul palco altre due artiste, prima delle quali è Vera Di Lecce, con la quale rilegge la di lei ‘Altar of Love’, brano sognante con spezie electro, che sembra quasi provenire da qualche disco più nascosto del catalogo 4AD o della Morr Music.
Discretamente dimenticabile, per usare un eufemismo, risulta invece la seconda ospitata, ovvero tale Valentina Polinori, con la quale esegue un brano di quest’ultima, una roba che pare uno scarto di Ariete partorito dalla penna di Coez. Non so se mi spiego.
Ma dopo quest’ultimo momento, che quasi ha ucciso il live, si torna su binari consoni con una versione di ‘Stay’ che invero mostra ancora qualche incertezza, per poi lasciare il posto alla title-track del suo secondo album – per l’appunto ‘Selva’ – brano in lingua madre dagli esperimenti vocali in loop, con cui la Del Grandi sembra porsi con gusto a metà strada tra Kate Bush e Meredith Monk, con tutte le dovute distinzioni del caso.
E poi, il colpo al cuore. Verso la fine, le prime note di “Hotel Supramonte” hanno attraversato la sala, accarezzando il pubblico con una delicatezza quasi sacrale. Marta non ha imitato De André: lo ha fatto suo, lo ha spogliato e rivestito di nuove fragilità, con la sua voce a posarsi sulla melodia con una dolcezza tagliente, creando un silenzio irreale in sala e provando lei stessa una palese emozione nel riproporla.
Il Monk, con la sua penombra accogliente, è stato il luogo perfetto per questa esperienza sonora: qui, lontano dai rumori della città, la musica di Marta Del Grandi ha trovato il suo spazio ideale: intimo ma espanso, raccolto ma in grado di aprire porte su altri mondi.
Un concerto che non è stato solo musica, ma immersione, come un dipinto da cui non riusciamo a distogliere lo sguardo, un universo sonoro che rimane addosso, come un sogno da cui non ci si vuole svegliare troppo in fretta.
Il cuore si perde in forme mai viste, come lei stessa canta.