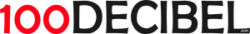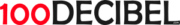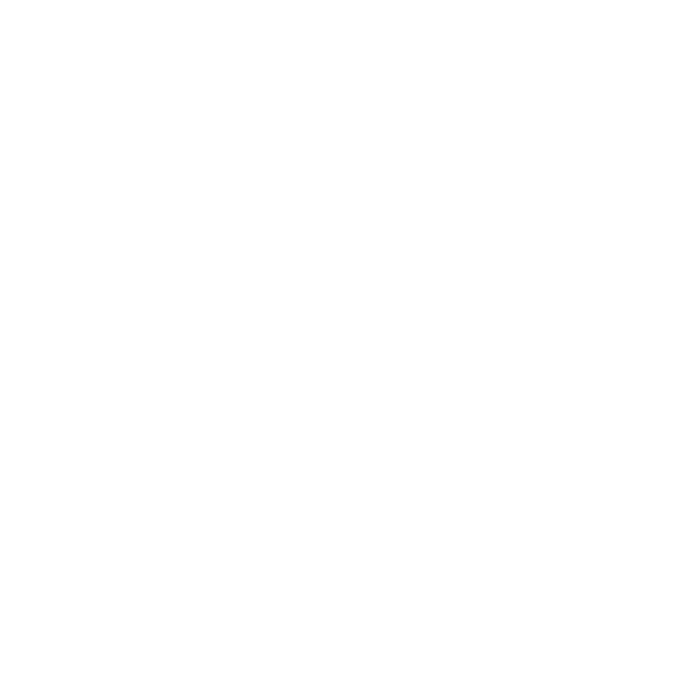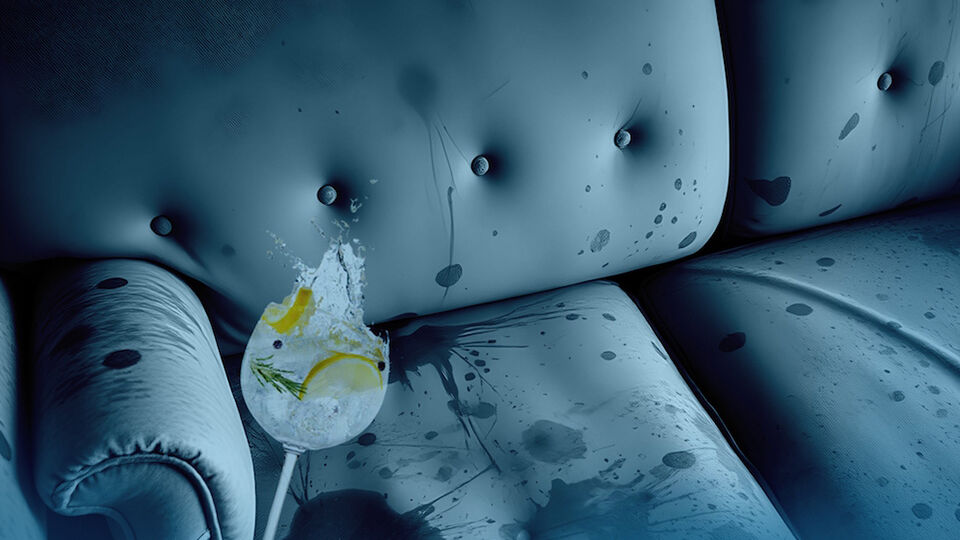C’è un silenzio quasi sacro nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma quando Brad Mehldau fa il suo ingresso. Il pianista statunitense, una delle voci più liriche e personali del jazz contemporaneo, si siede al centro del palco senza troppi preamboli, inclinando appena il capo, come per raccogliere dentro di sé l’energia della serata. Il pubblico lo accoglie con un applauso caloroso ma discreto, quasi timoroso di spezzare la magia che aleggia già nell’aria.
Il concerto si articola in due parti ben distinte, separate da una pausa di venticinque minuti: un intervallo oggettivamente troppo lungo, che rischia di interrompere l’immersione emotiva costruita fino a quel momento. Eppure, nulla sembra poter davvero scalfire il fascino magnetico della performance di Mehldau, capace come pochi di creare mondi sonori sospesi tra introspezione e virtuosismo.
Prima parte: il dialogo con Fauré
La prima parte è interamente dedicata alla rilettura di Gabriel Fauré, uno dei compositori francesi più raffinati del tardo Ottocento, la cui scrittura armonica e il senso melodico hanno avuto un’influenza profonda su Mehldau. Il pianista alterna trascrizioni di brani di Fauré a sue composizioni ispirate al suo stile, dando vita a un dialogo intimo e suggestivo tra passato e presente.
Le note fluiscono con una delicatezza impressionante, come se Mehldau le sussurrasse alla tastiera, lasciando spazio a ogni sfumatura armonica. Il tocco è vellutato, a tratti quasi impressionista, e le armonie si scompongono in frammenti che si rincorrono tra gli echi del repertorio classico e la sensibilità jazzistica. Non c’è un vero confine tra il Mehldau interprete e il Mehldau compositore: tutto si fonde in un unico respiro musicale, con passaggi in cui il pianoforte sembra cantare, evocando atmosfere sognanti e malinconiche.
Seconda parte: il jazz, tra originali e cover d’autore
Dopo la lunga pausa, il concerto cambia registro in modo netto. Il pianista ritorna sul palco con un atteggiamento più rilassato, quasi ironico nel modo in cui accenna un sorriso mentre si sistema al piano. La seconda parte è un’immersione nel suo mondo jazzistico, tra composizioni originali e riletture di brani rock e pop, sempre filtrati dalla sua sensibilità armonica unica.
Le cover sono il vero momento di sorpresa della serata. “Lithium” dei Nirvana viene trasformata in una ballata ipnotica, con un ostinato basso che sostiene le variazioni melodiche. “Independence Day” di Elliott Smith diventa un soffio delicato, quasi impalpabile, mentre “Optimistic” dei Radiohead viene scomposta in una serie di progressioni armoniche che ne svelano nuovi angoli di luce e ombra.
A un certo punto, arriva un momento di pura magia: Mehldau si lancia in una versione incredibile di “Here, There and Everywhere” dei Beatles. È un’interpretazione che lascia senza fiato per ricerca armonica e intensità emotiva. Il brano si snoda in una serie di modulazioni imprevedibili, con il pianista che gioca con la melodia, espandendola, contraendola, facendo emergere nuove sfumature e riverberi. È come se la canzone fosse stata riscritta da dentro, senza mai perdere la sua essenza ma guadagnando una profondità nuova, sospesa tra sogno e nostalgia.
Il finale della serata è affidato a “Waltz for JB”, una delle sue composizioni più celebri. Il valzer si sviluppa con eleganza, tra accenti spostati e armonie imprevedibili, in un gioco continuo tra tensione e rilascio. Mehldau danza con la tastiera, esplorando ogni possibilità melodica con la maestria di un vero narratore musicale.
Dopo il lungo applauso e i numerosi bis, il pubblico lascia la sala con la sensazione di aver assistito a qualcosa di raro: un concerto che ha attraversato epoche e generi con una naturalezza assoluta, nel segno di un pianista che continua a reinventare il proprio linguaggio senza mai perdere la sua anima poetica.