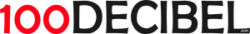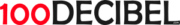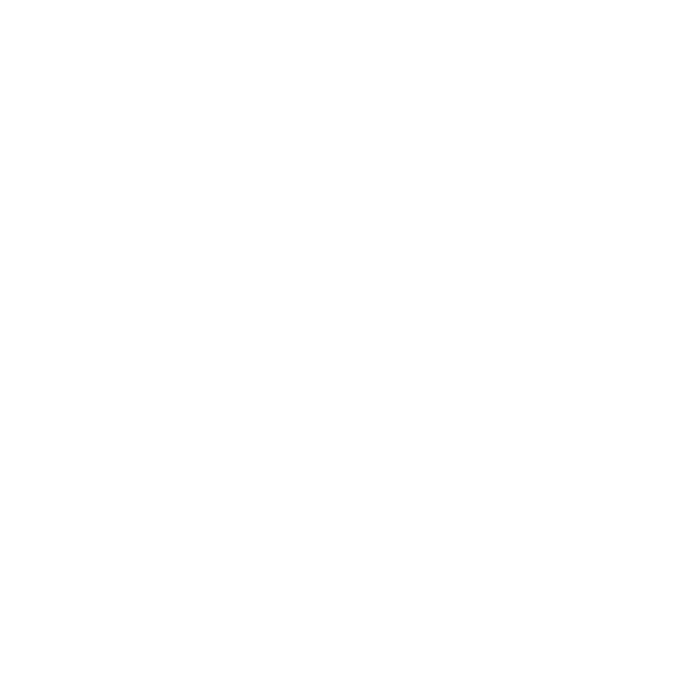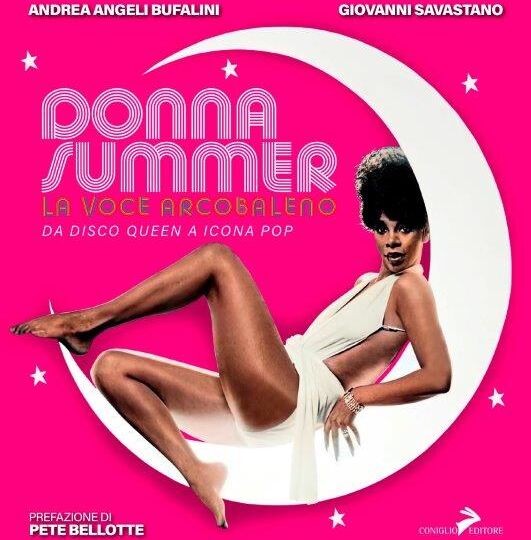La musica rappresenta da sempre una risorsa fondamentale per il genere umano, grazie alla sua immediatezza (si può far musica con qualsiasi cosa), per la sua universalità, per la possibilità di esprimere la nostra felicità ed esorcizzare la nostra tristezza. E quale miglior terapia d’urto se non la musica per affrontare queste settimane di clausura forzata?
Il nuovo modo di fruire della musica (mp3, download, spotify ecc…) ha fatto quasi del tutto scomparire un’abitudine che invece ha contribuito moltissimo alla crescita musicale ed emozionale di tante persone: l’ascolto per intero di un album dall’inizio alla fine, in vinile o LP, CD, insomma un qualsiasi supporto discografico con una raccolta di brani musicali di uno stesso artista. Magari lo facciamo ancora, ma spesso è solo un sottofondo mentre facciamo altro, guidiamo, cuciniamo, leggiamo le email, o mentre controlliamo le nostre onnipresenti piattaforme social, perché sempre di fretta, perché dobbiamo essere sempre connessi, perché dobbiamo andare, dobbiamo fare, dobbiamo vedere e sembra che di tempo non ce ne sia! Ma ora è diverso, di scuse non ce ne sono, all’alba del 14 marzo 2020 siamo costretti da un virus a stare dentro casa, e allora fermiamoci, sediamoci, sdraiamoci (con il cellulare distante) e, meglio di una terapia o di una seduta con uno psicologo, attraverso l’ascolto di un album senza interruzioni, senza salti casuali ma seguendo esattamente l’ordine delle canzoni dalla prima all’ultima, vedrete che quello che ascolterete veramente è voi stessi!
Ci sono album nella storia della musica il cui ascolto nella loro totalitaria interezza è un atto dovuto, una missione (non parlo solo dei così detti concept album); ne citerò solo alcuni, per importanza, per gusto personale, o perché pensando alla parola “album” sono quelli che la mia mente ha visualizzato per primi. Non deve essere una lista, che rischierebbe di essere infinita! Tutto questo è solo un’introduzione, uno spunto al quale ognuno può dar seguito con il proprio gusto musicale e che più lo emoziona!
Come apripista non ci si può esimere da quello che forse non è proprio il primo concept album della storia, ma sicuramente quello che ha dato forma e struttura all’idea stessa di concept album, dove la singola canzone non è solo fine a se stessa ma legata alle altre da un filo continuo, nel racconto di una storia o nell’espressione di un concetto: cari lettori… “so may I introduce to you, the act you’ve known for all these years, SERGEANT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAAAAAAAND!!!!!!!!!!” (l’ho scritta strillando e mi sono emozionata!).
Il 29 agosto del 1966 i Beatles fecero il loro ultimo concerto dal vivo (fatta poi eccezione dell’incredibile esibizione sul tetto degli Abbey Road studios a Londra nel ’69) con una decisione sofferta i Fab4 decisero di non esibirsi più dal vivo. A quel punto lo studio di registrazione diventò il loro unico campo di battaglia, dandogli così la possibilità di dare ampio spazio alla loro immaginazione musicale. Unico limite era il loro essere “i Beatles” quindi da qui l’idea di un alter-ego (o avatar per essere più attuali), appunto la Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e dar vita così ad un album tutt’altro che lineare! In realtà è come una primavera, solo che invece di un’esplosione di fiori e colori c’è un esplosione caleidoscopica di suoni e note, a rispecchiare questo è la chiassosa e discussa copertina dell’album; siamo nel 1967 e praticamente molte delle canzoni del disco erano pressoché impossibili da riprodurre dal vivo, i Beatles avevano davvero aperto un mondo sulle innumerevoli possibilità che lo studio di registrazione metteva a disposizione arricchita dalla incomparabile genialità melodica dei 4 di Liverpool! Scusate ma mentre scrivo la professionalità viene meno… Ma come avremmo fatto senza sti quattro!?? Come!?!?!?!? Ma questo non può essere spiegato, solo ascoltato!
Passaggio della staffetta ad un altro signor album, anzi per una sua compattezza di produzione ed esecuzione rasente la perfezione e per la longevità di permanenza nelle vendite dei dischi, direi “Il Signore degli Album”: THE DARK SIDE OF THE MOON dei Pink Floyd. Fermi, immobili, il viaggio lo farà la vostra mente, si eleverà fino a raggiungere il limite del cielo e poi su nello spazio senza gravità approderà sul lato oscuro della luna, e lì vi ritroverete faccia a faccia con la vostra follia e una luce negli occhi, la stessa che brillava in quelli di Syd Barret, ormai da anni fuori dal gruppo ma la cui presenza è sempre stata tangibile nella musica dei Pink Floyd, perché certe anime lasciano un segno indelebile nel cuore di chi le incontra. Le sensazioni e le emozioni non hanno corpo né peso, sono fatte di un entità spazio temporale non identificata, questo è per me The Dark Side of the Moon, certo nel 1973 acido e droghe a gogò, ma qui è l’ascolto della musica l’unica droga, che ti fa passare dal caldo al freddo, al sentire “delle voci”, fino ad emozionarsi con le lacrime agli occhi mentre viaggi sull’assolo di chitarra di “Time” o all’incredibile pathos creato dai cori di “Us and Them”… è difficile poi tornare con i piedi per terra!
In effetti non torniamo proprio con i piedi per terra, o per lo meno per terra si ma non proprio fermi; è il 1982 e nella musica di regnanti e nobili ce ne sono stati molti, un trono è ancora vacante ma un album porta con sé la corona che verrà posata sulla testa dell’unico Re che il pop abbia mai avuto: lui è Michael Jackson, l’album è THRILLER!
L’ enfant prodige dell’R&B anni ’70 era ormai maturato e con la complicità del produttore Quincy Jones ha creato il perfetto connubio tra l’essere un cantante, un ballerino ed un autore. Anche se sei nato nel posto più remoto della terra è insito ormai nel DNA del genere umano che appena partono le prime note di Wanna be startin’ somethin’ la tua testa comincia ad avere piccoli sussulti a ritmo, e dopo esserti scambiato convenevoli di “corte” con sir Paul McCartney, arrivi a Beat it che i tuoi calzini sono diventati bianchi e i pantaloni sono più corti (ma senza risvoltini) e sulle note di Billie Jean sei li sulla luna a fare il moonwalk con Syd Barret (ovvio). L’interpretazione immaginifica dell’album trova il suo trionfo nella teatralità dello spettacolare racconto horror di Thriller.
Nell’America di Reagan anni ’80 Michael Jackson rappresentava a pieno il sogno Americano, specchio se vogliamo della stessa realizzazione personale del quarantesimo presidente degli Stati Uniti d’America. Ma il sogno americano era per molti una promessa, anzi l’America “era” la terra promessa, fin dalla sua scoperta dalle coste europee in milioni rincorreranno i suoi immensi spazi sinonimo di possibilità, dall’Italia, dall’Irlanda: e proprio 4 irlandesi nel 1987 ci racconteranno un America diversa dall’edonismo reaganiano, un’America rurale, fatta di terra, sudore, del lento fluire del Mississippi, questa è l’America degli U2 nell’album THE JOSHUA TREE. Armoniche a bocca, gospel dalle tinte folk, scenari di guerra civile con chitarre metalliche come pioggia di proiettili, country dal sapore leggero o amaro, fede in Dio. Venduti, marchettari, negli anni un certo snobismo di basso livello si è accanito sui 4 ragazzotti irlandesi, a causa di troppa sovraesposizione o per un eccesso di proselitismo buonista, portando in certi casi a sminuire l’importanza che gli U2 hanno avuto in certi momenti storici musicali. Lo dimostra il fatto che The Joshua Tree sia un grande album, senza fronzoli, senza sovrastrutture, con una forte coesione di intenti nel voler omaggiare quella parte d’America meno luccicante, ma che ha creato la cultura e le tradizioni esportate poi nel resto del mondo: diamo agli U2 quello che è degli U2.
Diamo anche all’America quello che è dell’America, passando ad un vero eroe americano, uno a cui quell’America cantata dagli U2 gli scorreva nelle vene (non a caso gli U2 lo chiamarono a cantare sull’album ZOOROPA del 1993),un vero monumento, non solo in senso figurato, visto che la sua stessa consistenza sembrava fatta di pietra. Forte e tenace, con un incrollabile fiducia nello spirito americano: l’immenso JOHNNY CASH.
Era dal 1957 che Cash suonava nelle carceri e dal 1962 aveva desiderio di registrare uno di quei concerti. Finalmente nel 1968 il progetto vede la sua realizzazione: la mattina del 13 gennaio, accompagnato da i Tennessee Three, Carl Perkins, la Carter Family (con l’immancabile June, il grande amore della vita di Johnny Cash) e gli Statler Brothers, fa il suo ingresso all’interno del carcere statale di Folsom, il secondo più vecchio della California e noto per ospitare i peggiori criminali dello Stato, oltre ad essere il centro di una delle canzoni più famose. Venne al mondo così quel pezzo di storia della musica che è appunto JOHNNY CASH AT FOLSOM PRISON.
In modo del tutto paradossale l’ascolto di questo disco in questo preciso periodo storico può avere un valore aggiunto nell’immedesimazione con il pubblico presente a quel concerto, non dal punto di vista “criminale”, ma da quella di chi è costretto ad una chiusura forzata: quando qualcuno chiedeva a Cash del perché ci tenesse tanto a fare concerti nelle prigioni, la sua risposta era “per far sapere loro che non sono stati dimenticati”, ecco in considerazione di questo lascio ad ognuno di voi la libertà di fare una propria riflessione personale.
L’ apertura del disco e dell’entrata sul palco è puro Cash: “Ciao, io sono Johnny Cash”, con quella sua voce profonda, scurissima, e lui non scherza, ha fatto abbastanza concerti nelle carceri da sapere perfettamente le canzoni che avrebbero toccato l’anima di quelle persone. Quelle che parlavano di prigione, di crimini, separazioni e solitudine, a cominciare dal leggendario verso “I shot a man in Reno/ just to watch him die” in Folson Prison Blues, per poi proseguire in Cocaine Blues, o in 25 Minutes to go, dove i 25 minuti scanditi sono i 25 minuti che separano un condannato dall’impiccaggione. Il tutto sempre accompagnato da una sapiente dose di ironia e sarcasmo noire. La voce di Cash scava e rovista nelle viscere, mischia inferno e paradiso, ha screzi, imperfezioni, ma questa è la verità, la verità è imperfetta, e Johnny Cash non è mai stato perfetto, ma è sempre stato più grande della sua professione: era meravigliosamente umano.
Siamo finiti un po’ da dove siamo partiti, dagli anni 60, perché alla fine tutto torna, è un cerchio, come il cerchio della vita, dove finisce una cosa ne inizia un altra, e magari alla fine di questo articolo inizierà il vostro viaggio all’interno di un album, uno di quelli da me citati, o riprenderete in mano il vostro disco preferito, o quello che avete ascoltato in un momento particolare della vostra vita, o uno che non avete mai ascoltato, ma magari sarà diverso il modo in cui l’ascolterete, più vicino a voi stessi: questo è il mio intento, è un piccolo seme che spero germoglierà nei vostri impianti stereo o simili, facendo crescere un bellissimo albero carico di musica!
di Alessandra Tremoni